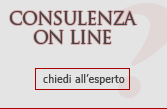DATORE DI LAVORO E’ CHI UTILIZZA IN CONCRETO LE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE – E’ un principio dell’ordinamento, anche dopo il decreto legislativo n. 276 del 2003, che ha introdotto eccezioni (Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza n. 22910 del 26 ottobre 2006, Pres. Carbone, Rel. Vidiri).
Anche dopo l’abrogazione della legge 23 ottobre n. 1369 (divieto di interposizione nel rapporto di lavoro subordinato) per effetto del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è principio fondamentale del nostro ordinamento che, salve le ipotesi eccezionali introdotte dal legislatore con la nuova normativa in materia di somministrazione di lavoro e di distacco, deve essere ritenuto effettivo datore di lavoro chi in concreto utilizza le prestazioni del lavoratore.
Lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte (sentenza n. 22910 del 26 ottobre 2006, Pres. Carbone, Rel. Vidiri) pronunciando su una vicenda svoltasi nella vigenza della legge n. 1369 del 1960. Nel caso esaminato dalla Corte, Giacomo P., formalmente assunto alle dipendenze della S.p.A. Winner’s Sporting Footwear, ha di fatto lavorato come direttore marketing della S.p.A. Master Sport facente parte dello stesso gruppo. Entrambe le società sono fallite. Il lavoratore ha chiesto ad entrambe le amministrazioni fallimentari, l’ammissione al passivo dei suoi crediti per differenze di retribuzione, t.f.r. e indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che in base alla legge n. 1369 del 1960 l’interposta Winner’s Sporting doveva ritenersi solidalmente obbligata con l’effettiva datrice di lavoro Master Sport. Il fallimento della Winner’s Sporting non ha accolto la domanda di ammissione al passivo. L’opposizione proposta da Giacomo P. contro questa decisione è stata rigettata dal Tribunale di Bari con sentenza che è stata confermata dalla locale Corte di Appello; le decisioni sono state motivate con riferimento all’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 secondo cui il lavoratore deve considerarsi a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato le sue prestazioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Bari per vizi di motivazione e violazione di legge. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, essendo stata constatata l’esistenza, nell’interpretazione della legge n. 1369 del 1960, di un contrasto di giurisprudenza nell’ambito della Sezione Lavoro, fra due orientamenti: in base al primo, in caso di interposizione del rapporto di lavoro, anche l’interposto deve rispondere delle obbligazioni verso il lavoratore (Cass. n. 1355/93, n. 3096/2001, n. 6144/2004, n. 6649/2004); in base al secondo l’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 deve essere interpretato nel senso che l’unico responsabile di tali obbligazioni sia l’interponente, in quanto effettivo datore di lavoro (Cass. n. 5901/99, n. 1733/2000). Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto pronunciandosi a favore del secondo orientamento e rigettando il ricorso del lavoratore.
La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 – ha affermato la Corte – mostra in maniera chiara come il legislatore abbia inteso seguire quella vasta corrente dottrinale e giurisprudenziale volta a svalutare la funzione del contratto individuale di lavoro e la formale conclusione dello stesso (quale fonte regolatrice del rapporto di lavoro) devolvendo in buona misura la disciplina dello stesso a fonti extranegoziali ed alla legge sino a pervenire alla conseguenza di individuare l’effettivo datore di lavoro attraverso una sostituzione di quello indicato dalle parti, mediante la manifestazione della loro volontà contrattuale, con quello che in concreto si giova dell’opera del prestatore. In altri termini – ha osservato la Corte – al fine di evitare ai danni del lavoratore un trattamento (sia sotto il versante economico che sotto quello normativo) ingiusto perché non corrispondente alle prestazioni rese e non parametrato sulla reale inserzione delle sue prestazioni nell’organizzazione produttiva dell’impresa, il legislatore si è attenuto al principio secondo cui il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l’altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull’esistenza di accordi fraudolenti (tra interponente ed interposto).
Per andare in contrario avviso – ha aggiunto la Corte – non può sostenersi neanche che l’indicato principio di carattere generale ha perduto consistenza giuridica a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 267 del 2003; detta disciplina, in una prospettiva di rinnovata rimodulazione delle relazioni industriali e del mercato del lavoro da perseguirsi anche mediante un accrescimento delle tipologie negoziali, ha invero espressamente riconosciuto con la somministrazione del lavoro (art. 20 d.lgs. cit.) – ed in certa misura anche con il distacco (art. 30 d.lgs. cit) – una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo con una consequenziale disarticolazione e regolamentazione tra i due degli obblighi correlati alla prestazione lavorativa (cfr. al riguardo tra le altre norme gli artt. 21-26 d.lgs. n. 267 cit). La indicata disciplina – ha precisato la Corte – pur presentandosi come una innovazione (seppure rilevante per le implicazioni di carattere teorico sulla sistemazione dogmatica del rapporto lavorativo) si configura anche nell’attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di “somministrazione irregolare” ex art. 27 cit. o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall’art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuta in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera. A conclusione della sua motivazione le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell’art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della mano d’opera negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni – comportano che solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi”.
__________________________________________________________________________________________
LA LUNGA DURATA DELLA DEQUALIFICAZIONE E’ ELEMENTO DI PROVA UTILIZZABILE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEL DANNO – In conformità con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6572 del 2006 (Cassazione Sezione Lavoro n. 22551 del 20 ottobre 2006, Pres. Est. Lupi).
Anna T. ed altri dipendenti della Telecom Italia, addette ai servizi del 187 e del 12 in modo promiscuo, con effetto dal luglio del 1997 sono state impiegate unicamente per il servizio del 12. Esse si sono rivolte, nel luglio del 2000, al Tribunale di Milano, sostenendo di avere subito una dequalificazione perché i servizi del 187 erano più qualificanti in quanto richiedevano interventi diversificati nel rapporto con il pubblico; pertanto esse hanno chiesto la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno professionale da loro subito. Sia il Tribunale che, in grado di appello, la Corte di Milano hanno ritenuto fondata la domanda ed hanno condannato l’azienda al risarcimento del danno. La Corte milanese ha ritenuto che la dequalificazione, essendosi protratta per oltre tre anni, abbia determinato una perdita di professionalità, con conseguente danno patrimoniale consistente in una perdita di valore sul mercato del lavoro. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22551 del 20 ottobre 2006, Pres. Est. Lupi) ha rigettato il ricorso richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 6572 del 2006 secondo cui: “In tema di demansionamento e di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico e esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione della integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni”.
Nella specie – ha osservato la Cassazione – le lavoratrici con i ricorsi introduttivi avevano adempiuto all’onere di allegazione, deducendo il danno professionale per perdita di valore sul mercato del lavoro, nonché per perdita di possibilità di carriera ed il danno alla personalità o esistenziale; accertata la dequalificazione professionale per il passaggio da una attività, che consisteva nel fornire informazioni anche di natura contrattuale al pubblico, promozione e vendita di servizi, ad una di mera ricerca di numeri telefonici ed indirizzi su elenchi, la Corte di Milano ha stabilito che la dequalificazione protratta per circa tre anni implicava una perdita di professionalità che si risolveva in un danno patrimoniale derivante dalla conseguente perdita di valore sul mercato del lavoro. La logicità di questo accertamento di fatto, fondato evidentemente sulla presunzione che lo svolgimento di un attività meno qualificata faccia venir meno o comunque diminuisca l’attitudine a mansioni più qualificate e che il valore di mercato di un lavoratore si fonda sul suo curriculum professionale – ha osservato la Cassazione – non è stata specificamente contestata dalla società ricorrente che si è limitata a citare giurisprudenza sulla necessità della prova del danno, quando questo era stato specificamente accertato alla stregua di presunzioni.
____________________________________________________________________________________
La prestazione lavorativa si presume svolta a titolo oneroso – Incombe al datore di lavoro la prova dell’eventuale gratuità – Ogni attività (compresa, quindi, quella giornalistica) oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di un terzo si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto in un settore disciplinato da un contratto collettivo; pertanto, qualora sia stato richiesto il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice può utilizzare gli elementi di fatto disponibili per la ricerca della effettiva natura, onerosa o gratuita, della prestazione accertata e, in mancanza di prova, che grava sul datore di lavoro, di una prestazione “affectionis vel benevolentiae causa”, ovvero a mero titolo didattico o di esperienza del lavoratore, può ricorrere anche alla valutazione equitativa per la determinazione dell’eventuale compenso spettante (Cassazione Sezione Lavoro n. 23528 del 2 novembre 2006, Pres. Ciciretti Rel. De Matteis).
_____________________________________________________
L’assenza del lavoratore per malattia comporta la proroga della durata del periodo di prova – Per l’effettività dell’esperimento – Debbono essere ricompresi nel periodo utile ai fini del superamento della prova anche quei giorni in cui la prestazione non è stata effettuata perché non prevista dall’articolazione del normale svolgimento del lavoro, quelli, cioè, in cui il lavoratore era legittimamente assente per festività, turni di riposo, fruizione di ferie, e eventi similari, prevedibili, e previsti, al momento della determinazione della durata della prova. Questo non esclude, però, che il periodo di prova debba essere soggetto ad interruzioni, per eventi, che, pur determinando la legittima astensione del lavoratore dalla prestazione, non siano previsti, né prevedibili, al momento della fissazione della durata della prova e non rientrano nella fisiologia del normale svolgimento del rapporto. Tra questi eventi rientra, in particolare, l’assenza per malattia. Non va dimenticato, in proposito, che entrambe le parti hanno reciprocamente il diritto di espletare la prova e l’obbligo di sottoporsi ad essa, e che l’interruzione dell’effettiva attività di lavoro per un periodo non previsto, specie se di non breve durata, impedisce il pieno espletamento del periodo di prova. Quest’ultimo pertanto deve necessariamente essere prorogato per consentire l’effettiva attuazione dell’esperimento. Anche la malattia, specie se prolungata, rientra tra gli eventi che comportano il prolungamento del periodo di esperimento.
Né questa soluzione comporta un’alterazione dell’equilibrio originario delle posizioni delle parti. In linea di principio, il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro. In particolare il prestatore avrà modo di espletare fino a fondo l’esperimento e di dare prova così pienamente delle proprie capacità, mentre il datore avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità ed entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto rendendolo a tempo indeterminato, o, invece, interromperlo. In concreto il prolungamento potrà risultare favorevole, o meno, a ciascuna delle parti, ma questo avverrà secondo le circostanze di fatto (Cassazione Sezione Lavoro n. 21698 del 10 ottobre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Monaci).
___________________________________________________
I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE DEVONO ESSERE SPECIFICI COMPLETI E RIFERIBILI ALLA DECISIONE IMPUGNATA – In particolare quando si denuncia la violazione di norme di diritto (Cassazione Sezione Prima Civile n. 22499 del 19 ottobre 2006, Pres. Luccioli, Rel. Bonomo).
Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata. In particolare, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c. deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
_____________________________________________________
La retribuzione per il lavoro straordinario non è vincolata a parametri rigidi ed inderogabili – In base all’art. 36 Cost. Rep. – La più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di non vincolare la retribuzione per il lavoro straordinario a rigidi ed inderogabili parametri economici, riconoscendo la piena legittimità di disposizioni di legge recanti la previsione di un compenso inferiore a quello erogato per l’orario ordinario e ribadendo che il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. si riferisce non ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario. Nella stessa direzione si è mossa anche la giurisprudenza della Suprema Corte, che, nel decidere una fattispecie nella quale, a causa del blocco preclusivo di qualsiasi modifica agli importi di trattamenti che includevano una quota dell’indennità integrativa speciale, ha riconosciuto la legittimità di un sistema normativo in base al quale il compenso per lavoro straordinario finiva nel corso degli anni per diventare inferiore alla retribuzione del lavoro ordinario e, conseguentemente, per non rispettare neanche il disposto dell’art. 2108 c.c.
Con riguardo, poi, all’ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è consentito alla stessa contrattazione determinare l’assetto degli interessi nel senso che il superamento dell’orario contrattuale fino al limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario. Non si tratta di contraddire il principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui è lavoro straordinario anche quello prestato oltre l’orario stabilito dal contratto (collettivo o individuale), siccome la fonte contrattuale, nell’escludere esplicitamente la disciplina retributiva propria del lavoro straordinario, sostituendola con una del tutto autonoma e diversa, manifesta l’intento di non considerare la protrazione di orario come lavoro straordinario (e cioè a prescindere da esplicite qualificazioni, come lavoro “supplementare” e simili, siccome la specifica regolamentazione del trattamento retributivo non consente dubbi interpretativi) (Cassazione Sezione Lavoro n. 22233 del 17 ottobre 2006, Pres. Ravagnani, Rel. Picone).
_____________________________________________________________
IL DIRIGENTE LICENZIATO PER RITORSIONE HA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO – Illiceità del motivo (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza del 27 ottobre 2006, Est. Tucci).
Giovanni Z. è stato assunto come dirigente alle dipendenze dell’Istituto di Credito Sportivo, con l’incarico di “responsabile dell’ufficio ispettorato e internal audit”. Pochi mesi dopo l’assunzione egli è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato senza preavviso con addebiti di inosservanza di disposizioni presidenziali e di inadeguatezza dell’opera prestata. Egli ha chiesto al Tribunale di Roma di disporre con provvedimento d’urgenza la sua reintegrazione nel posto di lavoro sostenendo che gli addebiti mossigli erano totalmente infondati e che in realtà egli era stato licenziato per ritorsione all’azione di controllo da lui svolta; ha richiamato in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la tutela reintegratoria spetta anche al dirigente ove il licenziamento sia stato disposto per motivo illecito di ritorsione ed ha comunque fatto presente di non essere un dirigente apicale.
La banca si è difesa sostenendo la fondatezza degli addebiti, negando l’esistenza di un motivo illecito e rilevando l’inapplicabilità al ricorrente della tutela reintegratoria in ragione della sua qualifica dirigenziale. Il Tribunale, dopo avere assunto informazioni, con ordinanza del 27 ottobre 2006 (Est. Tucci) ha disposto l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle mansioni svolte al momento del licenziamento. Il Tribunale ha rilevato l’infondatezza degli addebiti mossi al dirigente ed ha ravvisato nelle risultanze istruttorie sufficienti elementi per ritenere, sia pure con valutazione sommaria, l’esistenza di un motivo di ritorsione tale da viziare il licenziamento e rendere quindi possibile la tutela reintegratoria. Questa è stata comunque ritenuta ammissibile anche perché il lavoratore non aveva la posizione di dirigente apicale.