|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
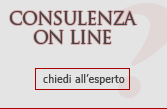 |
giovedì 7 ottobre 2004
La valutazione dei costi nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo: apertura alla teoria della “perdita attesa” e valutazione giudiziale della sua sostenibilità del dott. Flavio Vincenzo Ponte – Dottorando di ricerca in diritto del lavoro e relazioni industriali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Con grandissimo piacere ed onore, pubblichiamo di seguito il contributo dottrinale inviato alla nostra redazione dal dott. Flavio Vincenzo Ponte, componente del comitato scientifico di questa rivista giuridico-telematica. SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Brevi cenni sul giustificato motivo oggettivo nella l. n. 604/1966. 3. La teoria della “perdita attesa – costo opportunità”. 4. La sentenza del Tribunale di Palermo. 5. Conclusioni. La valutazione dei costi nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo: apertura alla teoria della “perdita attesa” e valutazione giudiziale della sua sostenibilità. (di Flavio Vincenzo Ponte – Dottorando di ricerca in diritto del lavoro e relazioni industriali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Brevi cenni sul giustificato motivo oggettivo nella l. n. 604/1966. – 3. La teoria della “perdita attesa – costo opportunità”. – 4. La sentenza del Tribunale di Palermo. – 5. Conclusioni. 1. La sentenza emanata dal Dott. Cavallaro, Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, in data 10 dicembre 2003 (Costa e a. - avv. Greco - c. Labisi Carlo & C. s.n.c. - avv. Bondi ) offre lo spunto per alcune brevi riflessioni su una questione di pregnante attualità ed enorme interesse: la definizione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, alla luce dell’interpretazione dottrinale/giurisprudenziale dell’art. 3, l. n. 604/1966, e conseguente determinazione dei “confini” della fattispecie. La genericità della espressione “giustificato motivo”, contenuta nel testo del 1966, ha indubbiamente incoraggiato gli interpreti a spendere le proprie energie onde individuare una costruzione teorico – interpretativa solida, soprattutto in fase patologica . In merito, un caso particolarmente interessante di “scambio” di opinioni, tra dottrina e giurisprudenza, è avvenuto riguardo alla sentenza Cass. , Sez. lav. , 5 marzo 2003, n. 3250: la Rivista Italiana di Diritto del Lavoro (2003, III) ha ospitato, all’uopo, i commenti del Prof. Ichino e dello stesso Dott. Cavallaro che, dalla su indicata pronuncia della Suprema Corte, hanno colto l’occasione per esprimere i propri orientamenti, contribuendo dunque a nutrire il dibattito in corso. 2. Secondo quanto previsto dall’art. 3, l. n. 604/1966, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sussiste per “ ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Ampio è stato il dibattito interessante tale norma, data la genericità dell’espressioni ivi contenute e la necessità di individuare un preciso significato dei termini utilizzati dal legislatore onde consentire ai giudici la corretta valutazione della legittimità del licenziamento per motivi diversi dal “notevole inadempimento” . In realtà non si può negare l’appartenenza alla nozione di g.m.o. , tanto di situazioni non riguardanti comportamenti del lavoratore, quanto di eventi a questo riconducibili: sebbene sia ovvio che un notevole inadempimento o un grave atto compiuto dal lavoratore porti al licenziamento per giustificato motivo soggettivo (oppure per giusta causa) è altrettanto vero che situazioni facenti capo al lavoratore possano influire sul “regolare funzionamento” dell’organizzazione del lavoro. Dunque bisogna tener conto dell’esistenza di fenomeni diversi che possono caratterizzare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Riguardo all’interpretazione delle ragioni giustificanti il recesso, è nota la tesi che tripartisce le stesse individuando elementi diversi onde qualificare i casi afferenti alla “attività produttiva”, alla “organizzazione di lavoro” ed al “regolare funzionamento di essa” . Rientrano nell’ambito delle ragioni inerenti all’attività produttiva, sicuramente le situazioni rilevanti ai fini del riassetto dell’organizzazione aziendale; tale caratteristica, peraltro, ci obbliga a coordinare la disciplina in esame con quella concernente i licenziamenti collettivi (l. n. 223/1991): infatti, i licenziamenti per motivi legati alla riduzione, trasformazione e cessazione di attività o lavoro oppure riguardanti la riduzione del personale, ex art. 24, l. n. 223/1991, non possono essere disciplinati (purché si rientri nei limiti numerici di cui al primo comma dell’art. 24) dall’art. 3, l. n. 604/1966; si ritorna, ovviamente, all’applicazione della 604/1966 ogni qualvolta non sussistano i presupposti per la riconduzione della fattispecie nell’alveo della l. n. 223/1991 (ciò, peraltro, poteva verificarsi abbastanza spesso, oltre che per mancanza dei requisiti numerici, anche per la natura stessa del datore di lavoro il quale, fino all’emanazione del D. Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 – adeguante la normativa italiana a quella comunitaria – doveva essere necessariamente qualificabile come imprenditore per poter rientrare nell’ambito di applicazione della legge in materia di licenziamenti collettivi). Un caso tipico di intervento di riassetto può essere quello della soppressione del posto di lavoro: in tal caso il datore di lavoro può licenziare il lavoratore impegnato presso il reparto interessato dalla soppressione, purché però il lavoratore interessato svolga mansioni tali da non poter essere utilizzato in azienda presso altri reparti bisognosi di forza lavoro (e, in tal caso, sempre nel rispetto del principio di cui all’art. 2103 c.c. vietante il demansionamento che, peraltro, non potrebbe essere lecito neanche a seguito di consenso dello stesso lavoratore). Pure è ammesso il licenziamento per g.m.o. quando la soppressione di un posto di lavoro è prodotta onde esternalizzare lo stesso, affidando il compito di svolgere l’attività a soggetti esterni alla realtà produttiva. Per ciò che concerne, invece, il trasferimento d’azienda, è il codice civile – art. 2112 – a prevedere che il trasferimento in sé non costituisce giustificato motivo di recesso. Sul piano squisitamente probatorio il datore di lavoro è gravato dall’obbligo di dimostrare il reale verificarsi delle situazioni che lo spingono a sopprimere il posto nonché l’impossibilità di riutilizzare il dipendente medesimo in altre mansioni equivalenti (ma, in merito, la stessa giurisprudenza è contraddittoria – cfr. infra) – trattasi della teoria del cosiddetto repêchage – ma non può essere obbligato dimostrare la validità dei motivi che lo hanno spinto alla ristrutturazione aziendale, essendo questi insindacabili dal giudice tanto sul piano della congruità quanto su quello dell’opportunità della scelta imprenditoriale (cfr. Cass., 30 maggio 2001, n. 7376) . Riguardo all’organizzazione di lavoro, intendendo con essa eventi finalizzati alla ristrutturazione aziendale, alla riconversione o alla riorganizzazione, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono considerabili legittimi se e nella misura in cui i lavoratori interessati non possano assolutamente trovare posto nella nuova organizzazione del lavoro stesso . In tali casi si parla, per lo più, di ridimensionamento dei programmi di sviluppo, mutamento dei prodotti commercializzati, drastica riduzione della redditività dell’impresa, o, più generalmente, di tutte quelle scelte imprenditoriali che rientrano in un riassetto organizzativo strettamente ancorato alla necessità di intervenire sul piano economico di gestione dell’impresa, escludendo ovviamente ogni intento pretestuoso , nonché esigenze datoriali legate ad un mero risparmio (cfr. Cass. , 14 giugno 1983, n. 4088). In merito, invece, al regolare funzionamento dell’organizzazione, vi è un ampio numero di casi potenzialmente annoverabili tra quelli idonei a giustificare un licenziamento per g.m.o. ; riveste, inoltre, particolare interesse tale ipotesi proprio perché, come supra si accennava, in essa confluirebbero tanto situazioni svincolate e non riconducibili alla figura del lavoratore, quanto eventi strettamente connessi con quest’ultimo. Ecco dunque che si ritorna a quella definizione particolare di g.m.o. legato a fenomeni “soggettivi” inidonei, però, a produrre il notevole inadempimento che giustificherebbe il ricorso ad altro motivo di recesso da parte del datore di lavoro e tali, invece, da caratterizzare in senso oggettivo il fatto impeditivo (cfr. Cass. , 22 luglio 1993, n. 8152). Tipico esempio può essere rappresentato dal lavoratore divenuto qualitativamente o quantitativamente inadeguato, nei casi di cosiddetto scarso rendimento dovuto a sopraggiunta incapacità personale o professionale. In tale senso, come autorevolmente sostenuto (Pera), l’analisi del fenomeno diviene complessa e spinge ad una valutazione della situazione professionale, in cui versa il lavoratore, di stampo prettamente obiettivo per meglio cogliere i riflessi che essa produce sulla organizzazione di lavoro. All’uopo anche la Suprema Corte si è pronunciata, facendo convergere nell’art. 3 anche tutte quelle “ipotesi di non regolari prestazioni di lavoro [...] ascrivibili però a cause non imputabili – al lavoratore – che siano di entità tale da escludere l’oggettivo interesse produttivo dell’impresa a mantenere in vita il rapporto e ricevere le ulteriori possibili prestazioni” (Cass. , 20 gennaio 1987, n. 476); considerato che il dibattito che oggi è posto al centro di queste brevi note ruota proprio intorno alla relazione che sussiste tra gli obblighi del datore di lavoro, relativi al mantenimento in vita di un rapporto antieconomico per lo stesso e il diritto del lavoratore a conservare la propria fonte di reddito, non è inutile domandarsi quale sia la natura degli interessi in gioco e, soprattutto, come quantificarli onde produrre un giudizio di prevalenza relativa (cfr. infra). Dunque lo scarso rendimento impone, ai fini di un legittimo recesso, una valutazione complessa che, tenendo conto dell’organizzazione produttiva e del normale svolgimento della stessa, alla luce dell’economia del rapporto di lavoro, consideri tutte le variabili e tutti gli strumenti utilizzabili in ossequio al principio – dalla giurisprudenza sostenuto – che vede, comunque, il licenziamento come extrema ratio, onde consentire di recuperare il lavoratore: così la già citata giurisprudenza (cfr. Cass. , n. 8152/1993, cit.) ribadente, in merito, che lo stesso datore di lavoro, nel rispetto degli artt. 1175 e 1375 c.c. e prima di procedere al licenziamento, deve fornire tutta la cooperazione necessaria al lavoratore per eliminare gli ostacoli al corretto adempimento. Il recesso, quindi, sarebbe legittimo proprio quando la natura dell’inidoneità e la sua durata sono tali da ritenersi incompatibili con la causa giuridica del rapporto medesimo, nonostante gli “sforzi” del datore di lavoro. Suggestive appaiono, peraltro, le teorie che, prendendo spunto dall’indubbia sinallagmaticità permeante il rapporto di lavoro, riconducono ai casi di erogazione impossibile della prestazione (indeterminata o indeterminabile nel tempo) la conseguenza della risoluzione ipso iure (Cass. 8 gennaio 1983, n. 140) del rapporto stesso, ovvero – così anche la giurisprudenza più recente – che ammettono il recesso del datore di lavoro ex art. 1464 c.c. ogni qual volta tale inadempimento produca il venir meno dell’interesse di questo all’erogazione della prestazione lavorativa ridotta a causa della mancanza di una completa capacità di lavoro. Ancora in merito al regolare funzionamento, possono citarsi i casi riguardanti la cosiddetta carcerazione preventiva e le assenze per malattia (unitamente ai fenomeni della eccessiva morbilità e del superamento del periodo di comporto). Preliminarmente, in riferimento al primo caso e pur accennandovi brevemente non potendo, in tal sede, dar completa notizia degli ampi studi e dell’abbondante giurisprudenza esistenti, non si può tacere dei dubbi concernenti proprio la recente modifica apportata dal legislatore, con l’art. 24 della l. n. 332/1995, al codice di procedura penale (cfr. nuovo art. 102 bis delle norme di attuazione): tale novella infatti, nel prevedere, per il lavoratore licenziato a causa della sottoposizione a misura di custodia cautelare ex art. 285 c.p.p. ovvero a quella degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. , il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione, trasferisce, parzialmente, sul datore di lavoro il peso della giusta riparazione che dovrebbe spettare completamente allo Stato. Parzialmente perché, in effetti, la reintegrazione produce solo effetti ex nunc non obbligando il datore di lavoro, giacché “terzo” rispetto alle vicende processuali producenti il diritto alla riparazione, al pagamento della retribuzione o degli oneri previdenziali per il periodo intercorso tra il licenziamento e l’effettivo reinserimento del lavoratore nel contesto produttivo. Ebbene è proprio l’esistenza di un datore di lavoro indubitabilmente “terzo” a destar dubbi sulla legittimità di un tale peso a suo carico, alla luce di codesti effetti diretti della sentenza penale sul rapporto di lavoro . Se, dunque, non può intravedersi nella carcerazione preventiva una fattispecie – tipo giustificante il recesso da parte del datore di lavoro (salvo i casi in cui il fatto penalmente rilevante costituisca un notevole inadempimento contrattuale, tale da giustificare il recesso per g.m.s. o giusta causa), con ciò negando, quindi, effetti negativi diretti sul rapporto (cfr. in tal senso Cass. , 28 luglio 1994, n. 7048), è però necessario considerare, in tali casi, l’incidenza dell’assenza del lavoratore (provocante una sopravvenuta impossibilità – temporanea – della prestazione lavorativa) sull’economia del rapporto stesso, alla luce di quanto contenuto nell’ art. 3, l. n. 604/1966: quindi in ragione del tipo di attività produttiva, di organizzazione e delle mansioni affidate al lavoratore, nonché di ogni altra misura della tollerabilità dell’assenza, si dovrà valutare il costo sopportato (e sopportabile) dal datore di lavoro onde legittimare – o meno – un recesso per g.m.o. Senza dubbio anche l’elemento temporale costituisce un particolare fondamentale nell’ambito delle valutazioni su richiamate e necessarie al fine del corretto inquadramento del problema; è stato argutamente sostenuto , infatti, che la durata dell’assenza a causa della carcerazione preventiva debba eventualmente prevalere su altri parametri, assurgendo a pilastro fondamentale ai fini della compressione della libertà datoriale, nell’organizzazione di impresa e concernente il regolare funzionamento della stessa. Tutto quanto detto, peraltro, deve caratterizzare un’attività di indagine di natura prettamente prognostica, volta cioè a determinare l’incidenza dell’assenza del lavoratore sul regolare funzionamento dell’organizzazione di lavoro ex ante, non solo dunque per il periodo di carcerazione già maturato, bensì anche per il possibile lasso di tempo futuro. Riguardo alle assenze per malattia, l’eccessiva morbilità ed il superamento del periodo di comporto, la valutazione, da parte del datore di lavoro, dei presupposti ai fini del recesso deve, necessariamente, essere coerente col disposto dell’art. 2110 c.c. Esso, infatti, vieta il recesso fino a quando l’assenza per infortunio, gravidanza, malattia o puerperio non superi il limite massimo predisposto dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o dall’equità (cd. periodo di comporto). La peculiarità della disciplina si evince dal fatto che, sussistendo il succitato superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro è legittimato a recedere senza dover osservare i limiti posti dalla legge all’esercizio di tale facoltà. Se, dunque, il licenziamento non deve esser rispettoso della normativa vincolistica in materia può ben definirsi, codesto caso, non rientrante nell’alveo del g.m.o. ; in tal senso anche la giurisprudenza che ha confermato l’applicabilità di tale licenziamento anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 604/1966, elevando il caso previsto dall’art. 2110 c.c. ad autonomo e speciale motivo di licenziamento e, quindi, esonerando il datore di lavoro da un’eventuale ulteriore prova del giustificato motivo (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n. 1973; Cass. 12 giugno 1995, n. 6601). Pacifico è l’orientamento, inoltre, che considera il periodo di malattia ai fini del calcolo del comporto non già come fenomeno unico continuativo ed ininterrotto, bensì comprensivo anche delle ipotesi di assenze reiterate, ancorché frequenti e discontinue (cd. eccessiva morbilità). Il problema più frequente, in tali casi, è quello riguardante la corretta definizione del comporto per sommatoria, alla luce dell’inesistenza, in molti contratti collettivi, di previsioni disciplinanti, in aggiunta al cosiddetto comporto secco, i casi di assenze reiterate per malattia ai fini del recesso. Il richiamo dell’art. 2110 c.c. agli usi ed all’equità e la già cennata esclusione della fattispecie in esame dall’ambito di applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti contenuta nella l. n. 604/1966 e l. n. 300/1970, dovrebbe indurre il giudice a ricorrere proprio a tali fattori (usi ed equità) in assenza di un intervento eteronomo/autonomo; se invece è previsto nel contratto collettivo il solo comporto secco, una volontaria esclusione dei casi di morbilità ai fini del recesso comporta, secondo la S.C. (contraddicente, peraltro, proprio precedente orientamento), la nullità del contratto nella parte in cui esso viola il contenuto dell’art. 2110 c.c. , considerandosi tale norma inderogabile (cfr. Cass. 14 ottobre 1993, n. 10131). Dunque in assenza di specifico intervento della contrattazione collettiva ed in mancanza di usi, dovrà essere il giudice a valutare, in via equitativa, la legittimità del recesso in relazione alla durata delle assenze in un determinato lasso di tempo. 3. Appare chiaro, dunque, che l’intervento giudiziale volto a valutare la liceità del recesso per g.m.o. è particolarmente delicato, proprio a causa delle incertezze cui si è accennato. La questione è complicata proprio dal riferimento normativo a fattori difficilmente conoscibili e “pesabili” dallo stesso giudice (il quale, ovviamente, non è un imprenditore né ha contezza delle forze e dei fattori che regolano ed influenzano il mercato) che, oltre a ciò, nello svolgimento delle “operazioni” incontra i limiti costituzionali posti a tutela dell’iniziativa economica privata, efficacemente collocati a protezione dell’opportunità e della congruità delle determinazioni dell’imprenditore. Quindi il magistrato dovrà solo limitare la propria indagine all’effettiva sussistenza dei fattori allegati a sostegno del recesso ed all’esistenza del necessario nesso di causalità; è però fondamentale valutare, altresì, l’idoneità di codesti fattori a costituire adeguato e giustificato motivo di licenziamento e, data l’assenza di una specifica tipizzazione, proprio in tal senso il compito del giudice si manifesta più arduo. Determinare fino a che punto (o, com’è stato osservato, fino a quale soglia) il datore di lavoro debba “subire” gli eventi negativi che rendono il rapporto antieconomico e, in ogni modo, meno produttivo, non è dunque agevole. All’uopo, la teoria elaborata dal Prof. Ichino: “ il lavoratore può essere licenziato quando dalla prosecuzione del rapporto derivi per l’impresa, in termini di valore atteso, una perdita (derivante da costi contabili o da costi – opportunità, cioè da minor reddito prodotto rispetto a quello che sarebbe prodotto da altro lavoratore disponibile) superiore ad una soglia di sopportabilità ” ; tale soglia, peraltro, non essendo determinata dalla norma, deve essere stabilita dal giudice caso per caso . Comprensibilmente il g.m.o. non può essere costituito da qualsivoglia perdita attesa, in quanto è necessario che il datore di lavoro tema di subire perdite apprezzabili, sul piano economico, a causa della prosecuzione del rapporto di lavoro: dunque la soglia non può che consistere in un valore osservabile sul piano squisitamente economico , tale per cui il superamento della stessa comporti un sacrificio – costo intollerabile per il datore di lavoro (che, altrimenti, nessun interesse avrebbe a liberarsi di un lavoratore produttivo); la perdita attesa, altresì, non può essere una perdita minima, perché diversamente si svuoterebbe di contenuto la stessa norma limitativa del recesso, dunque la soglia rappresenta proprio il livello al di sotto quale il datore di lavoro deve sopportare il “peso” della prosecuzione del rapporto stesso. In merito alla perdita attesa, è chiaro che la stessa debba desumersi a seguito di una valutazione prognostica tale da consentire una visione preventiva del possibile scenario concretizzabile; è opportuno specificare, però, che codesta valutazione non può attenere ad una futura perdita inerente l’attività d’impresa nel suo complesso (dunque, per esempio, una possibile perdita di bilancio), bensì deve essere pertinente al singolo rapporto di lavoro: sono le vicende interessanti il singolo rapporto, infatti, a poter giustificare un recesso nell’ ipotesi in cui dal prosieguo derivi una perdita per il datore di lavoro. Il punto cruciale è proprio questo quindi: il bilancio aziendale può essere o meno in perdita, ma ai fini del recesso per g.m.o. ciò poco importa, poiché è indispensabile che il datore di lavoro si attenda una perdita (oltrepassante la nota soglia) dal proseguimento del singolo rapporto per far sì che il recesso sia lecito; proprio in tal senso si rivela, dunque, necessario soffermarsi sui concetti di costo – opportunità e costo – contabile onde meglio cogliere quali sforzi dovrà produrre il datore di lavoro in siffatto contesto. Così il Prof. Ichino: “la retribuzione pagata al lavoratore rappresenta un costo contabile, in quanto figura come tale nella contabilità aziendale; se però il mantenere il lavoratore al suo posto impedisce di collocare a quel posto un lavoratore più produttivo o di utilizzare una macchina che consentirebbe di guadagnare di più, questo maggior guadagno perduto costituisce un costo – opportunità: un costo cioè, che non figura nei libri contabili, ma non per questo è meno rilevante nella vita dell’azienda” ; dunque ci troviamo dinanzi a due distinti concetti che possono ben essere utilizzati nel complesso calcolo volto a bilanciare gli interessi degli attori, ma che non possono però essere confusi. Il problema sembra essere, considerato anche il caos giurisprudenziale in merito , non tanto quello di discriminare tra i costi, al fine di identificare quali siano ontologicamente idonei a sostenere il recesso e quali non lo siano, bensì quello di quantificare gli stessi onde valutarne l’entità, giacché proprio tale operazione deve svolgere il giudice per verificare il superamento della soglia (cfr. infra). L’ impostazione teorica cui in tal sede, brevemente, si accenna, poggia su un più ampio costrutto che colloca il rapporto di lavoro nell’alveo dei rapporti a contenuto assicurativo; del resto non potrebbe essere altrimenti, non sussistendo una giustificazione lecita all’imposizione, nei confronti del datore di lavoro, della prosecuzione di un rapporto di lavoro “in perdita” salvo ammettere, appunto, il valore assicurativo dello stesso, per cui il dipendente è coperto da sopravvenienti rischi (ed entro la famosa soglia) proprio dal datore di lavoro che se ne fa carico, come un assicuratore, coprendo le perdite e garantendo la stabilità del rapporto stesso . Tuttavia la succitata funzione è assolta a prescindere dal verificarsi o meno degli eventi negativi dai quali il lavoratore è protetto: anche se l’aleatorietà (per i dubbi sulla natura aleatoria dei contratti a contenuto assicurativo cfr. Ferrari, ivi cit.) è data dall’incertezza del verificarsi dell’evento, il vincolo contrattuale assolve, nondimeno, le sue funzioni per il solo fatto di fornire garanzia verso pagamento del premio . Quindi si può visualizzare tale struttura come un articolato bilanciamento degli interessi in campo per cui, fino al raggiungimento della soglia – massimale, il datore di lavoro è tenuto a coprire tutti i potenziali rischi, agendo come uno “scudo” ed offrendo stabilità al lavoratore dipendente, naturalmente, rinunciando al soddisfacimento dei propri interessi in merito (rectius rinunciando a liberarsi del lavoratore) e, indubbiamente, subendo i costi che le dinamiche in gioco producono; superato il limite di cui supra, il datore di lavoro non è più tenuto ad assicurare il lavoratore dai rischi e, dunque, può (e, indubbiamente, non deve) liberarsene – lecitamente – non sussistendo, nella logica pervadente la struttura contrattuale in oggetto, l’obbligo di tollerare un costo eccessivo, ovvero eccedente il massimale. Quanto detto potrebbe indurre a ritenere esistente uno sbilanciamento nei confronti del lavoratore, il quale sembrerebbe esser l’unico a trarre beneficio dal rapporto assicurativo – di lavoro. In realtà così non è: il datore di lavoro ha interesse a svolgere il “ruolo” di assicuratore in tale struttura contrattuale al fine di godere del “premio assicurativo implicito” che rende conveniente il rapporto. Tale premio assicurativo consiste in una riduzione dei livelli retributivi e, dunque, in un risparmio: il datore di lavoro, infatti, offrendo sicurezza e stabilità, eroga una somma di danaro certamente inferiore a quella che il lavoratore potrebbe incassare (e dunque utilizzare come riferimento nella pattuizione del livello retributivo) se operasse liberamente sul mercato. Invero in tal caso il lavoratore potrebbe avvantaggiarsi di introiti maggiori, proprio per il fatto di agire direttamente sulla “piazza” e, dunque, di poter stabilire il corrispettivo per le proprie prestazioni secondo le normali regole di mercato; in tal caso, però, dovrebbe subire anche gli effetti negativi che l’essere attivo in un mercato concorrenziale comporta: potrebbe collassare la domanda a causa di eventi esterni nefasti; potrebbe maturare una forte concorrenza, nel settore di competenza, tale da ridurre sensibilmente i profitti; il progresso tecnologico potrebbe produrre effetti negativi, etc. Ergo, il datore di lavoro si giova della disponibilità – del lavoratore – a rinunciare ad una fetta di retribuzione (il premio appunto) impegnandosi, per contro, a mantenerlo indenne da eventi negativi futuri, naturalmente fino a che ciò non produca un costo esuberante la soglia – massimale cui si è cennato. Il sussistere, nel rapporto di lavoro, un contenuto assicurativo è conseguenza di una complessa articolazione degli interessi – meritevoli di tutela costituzionale – in campo: secondo tale visione, infatti, le “anomalie” del mercato del lavoro, le peculiarità afferenti alla posizione degli attori, nonché le caratteristiche di tali ultimi, costituiscono la base per una allocazione del rischio, concernente le sopravvenienze negative, squilibrata e non ottimale. Se così è, l’intervento eteronomo si palesa necessario per ristabilire una migliore e più equa ripartizione del rischio stesso: di fatto, se non esistesse un contenuto assicurativo, la parte contrattualmente più forte (dunque il datore) potrebbe approfittare della propria posizione sul mercato; peraltro il lavoratore, al fine dell’ottenimento di un impiego, sarebbe propenso a nascondere, al datore di lavoro, informazioni potenzialmente negative concernenti la propria persona e quindi, per rendersi più “appetibile”, a rinunciare preventivamente a qualsivoglia tipo di garanzia permeante il rapporto (per es. copertura dei periodi di malattia, gravidanza, ferie etc.). Ecco dunque che il datore di lavoro è costretto, dalla norma, a svolgere una funzione assicurativa per garantire un livello accettabile di tutela, in un tipo di rapporto in cui emergono posizioni particolarmente delicate e meritevoli di protezione: in tale “letto” scorre, quindi, la disciplina limitativa del recesso. Elemento importante di tale riflessione, dunque, appare essere proprio quel rischio che la norma cerca di ripartire equamente tra gli attori. All’uopo la teoria della propensione al rischio, elaborata da Knight, ben coglie le peculiarità del rapporto di lavoro e dei protagonisti dello stesso nonché degli interessi in gioco: in un mondo in cui vi è profonda incertezza circa le potenziali sopravvenienze negative, i soggetti si distinguono in propensi (o neutrali) al rischio ed avversi al rischio; i primi – datori di lavoro – non temono le citate negatività e si sobbarcano i costi ed i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di impresa, i secondi – lavoratori dipendenti – non sono disposti a tanto e, dunque, preferiscono rinunciare a più alti margini di guadagno pur di ottenere stabilità economica e serenità da colui a favore del quale mettono a disposizione le proprie energie lavorative; quest’ultimo, in cambio, dovrà sollevare il lavoratore da tutti i rischi inerenti alla gestione d’impresa o all’andamento di mercato. Dunque siffatta teoria giudica la subordinazione una diretta conseguenza della stipula di tale contratto di assicurazione, nell’ambito di una differente propensione al rischio – inteso come pericolo di perdita patrimoniale (così il noto brocardo latino: periculum pecunia aestimatur) – degli individui. Alla luce di quanto detto appare più chiaro che, l’intervento legislativo volto a limitare il recesso da parte del datore di lavoro, risponde a quella naturale esigenza di protezione avvertita da soggetti i quali, non optando per la propensione (o la neutralità) al rischio, ricorrono al rapporto di lavoro subordinato al fine di neutralizzare i rischi stessi – fino a concorrenza del massimale. Ritornando al fulcro del discorso, ovvero alla soglia, restano da chiarire il quantum ed il procedimento logico necessario onde pervenire ad un giudizio di liceità del recesso per g.m.o. Ebbene, il procedimento logico che il giudice deve seguire non può che prendere spunto dalla stessa perdita attesa addotta dall’imprenditore a motivo del recesso: se quest’ultimo è pervenuto ad un licenziamento ricorrendo al g.m.o. vuol dire che egli ritiene assolutamente improseguibile il rapporto con il lavoratore a causa del costo che la perdita attesa comporta e, se ciò è vero, tale costo può fungere da linea di demarcazione o, meglio, assurgere a vero e proprio firing cost onde verificare la sussistenza dei motivi allegati per cui il datore di lavoro, adeguatamente sollecitato dal giudice, dovrebbe essere disposto a pagare una cifra pari – ma non superiore – a quella che sarebbe necessaria per mantenere il rapporto in vita, al fine di dimostrare le proprie buone ragioni. Si tratta, in parole povere, di sottoporre il datore di lavoro al cosiddetto revelation principle, ossia, utilizzare un metodo estremamente razionale volto a verificare se sussiste realmente una perdita attesa: ricorrendo a tale schema, infatti, e facendo forza sul principio secondo cui un soggetto è disposto a pagare, per ottenere un bene, una cifra pari alla misura dell’utilità che ricaverà dal bene stesso, il datore di lavoro sarà disposto a erogare una somma tale da essere inferiore o, al massimo, uguale al costo derivante dalla perdita che si attende dal prosieguo del rapporto di lavoro; oltre non sarebbe disposto pagare poiché, superando codesta soglia, gli costerebbe meno mantenere in vita il rapporto che scioglierlo. Come si può ben notare le fondamenta di tale teoria poggiano sulla considerazione che i costi derivanti dalla perdita, conseguente al mantenimento in vita del rapporto di lavoro, siano determinati o determinabili: il problema – e giungiamo al famoso quantum – consiste proprio nel fatto che, in assenza di un intervento legislativo volto a determinare un firing cost (vedi infra), e dinanzi all’impossibilità di affidarsi alle valutazioni imprenditoriali in merito (il datore di lavoro potrebbe indicare un firing cost relativamente basso o comunque accessibile se volesse – simulando un recesso per g.m.o. – sbarazzarsi del lavoratore), dovrà essere proprio il giudice a sforzarsi di trovarne la misura. In realtà, anche allontanandosi dalla costruzione teorica di cui si narra, poco cambia giacché, oggi, i giudici – nella pratica – non fanno altro che valutare la sopportabilità del costo derivante dal prosieguo del rapporto secondo criteri economici (sebbene poi, nelle motivazioni delle sentenze, non esplicitino mai il percorso logico che nutre la decisione, ricorrendo invece a sterili “formule” e mai chiarendo perché il costo paventato sia o meno idoneo a giustificare un recesso) e, dunque, individuando di volta in volta una sorta di firing cost che, seppure non esplicitato o proposto ex ante, ne condiziona la decisione a favore o meno del datore di lavoro; decisione che sarà, senza dubbio alcuno, fondata sull’intima convinzione che la perdita attesa sia tale da giustificare o meno il recesso, per il solo fatto che la stessa si manifesti – al giudice – più o meno idonea legittimarlo. Nessuna regola generale può derivare, dunque, dall’analisi della giurisprudenza in materia: cercando di “chiudere il cerchio” mediante il ritorno alla regola, cioè, all’art. 3 della l. n. 604/1966, non si può decisamente definire quale orientamento giurisprudenziale meglio combacia con il contenuto precettivo della norma richiamata. 4. Orbene proprio la su indicata incertezza circa le motivazioni contenute nelle pronunce dei giudici aventi ad oggetto il recesso per g.m.o. rende ancor più interessante il dibattito a distanza, tra dottrina e giurisprudenza, cui supra si cennava. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, con sentenza del 10 dicembre 2003, dimostra una certa apertura alle teorie su esposte, riconoscendo l’esistenza di una perdita attesa da valutare, ex ante, onde lecitamente recedere per g.m.o. ; rilevante è, peraltro, il riferimento – voce fuori dal coro – ai due “tipi” di costo (opportunità – contabile) giacché dimostra una certa attenzione a quanto la teoria economica ha elaborato fino ad oggi in merito e, più di ogni altra cosa, esplicita proprio la natura economica dei motivi sottendenti al licenziamento. Tale provvedimento giurisdizionale, dunque, palesa un indubbio interesse verso la nuova interpretazione dell’art. 3, l. n. 604/1966; il giudice implicitamente riconosce la necessità di dotarsi di una visione interdisciplinare dei fenomeni giuridici concernenti il rapporto di lavoro il quale, nella dimensione patologica, pone a dura prova la cultura giuridica degli interpreti, richiedendo una certa elasticità ed apertura mentale agli stessi onde poter meglio comprendere la complessa interazione degli interessi in gioco. Considerato, altresì, quanto espresso dallo stesso Dott. Cavallaro in altra sede (cfr. RIDL, 2003, III), evidenti appaiono i riferimenti alla tradizionale interpretazione del recesso per g.m.o. , in linea con la giurisprudenza prevalente: il Giudice, infatti, sebbene concordi sulla necessità di verificare la sussistenza della perdita attesa, non riconosce la necessità di determinarne l’entità, con ciò dunque intaccando la superficie del problema, senza però penetrare a fondo; inoltre, così facendo, esclude la natura assicurativa del rapporto, senza però spiegare come si possa giustificare l’obbligo, per il datore di lavoro, di sopportare il mantenimento di un rapporto in perdita (nell’ipotesi in cui lo stesso Giudice accolli tale perdita al datore). Il concentrare, dunque, le proprie energie sull’ an è indubbiamente necessario, ma il tenersi lontano dal quantum evidentemente non consente di elaborare un criterio certo (ed applicabile a tutti i casi) al fine di verificare quando il recesso è legittimo; la nebulosità di tale operazione è tradita, in realtà, dalle stesse parole del Giudice, affermante che “non c’è nulla di strano, in linea di principio, nel fatto che l’ordinamento imponga al giudice di dire all’imprenditore < Quindi non si può non tornare all’impostazione teorica da cui si è partiti: se è vero – come è vero – che lo stesso giudice svolge un’operazione di calcolo della perdita attesa onde relazionarla a ciò che egli ritiene un peso “ragionevole”, non si capisce come ci si possa poi mantenere distanti dal definire l’entità del costo derivante dalla perdita stessa (ovvero chiarire come si determini il “ragionevole”), ravvisato che proprio esso svolgerà il ruolo cardine in merito alla definizione della questione; ancora poi il non voler determinare la suddetta entità, vuol dire non voler riconoscere la natura assicurativa del rapporto e l’esistenza di una soglia/massimale – al di sotto della quale il premio pagato dal lavoratore lo mantiene indenne dalle sopravvenienze negative ed oltrepassata la quale il datore è libero di recedere – lasciando dunque aperta la questione circa il fondamento giuridico dell’esistenza di un limite al recesso del datore di lavoro per motivi diversi dal notevole inadempimento. Le perplessità su esposte, peraltro, traggono maggior linfa proprio da altro passaggio contenuto nella motivazione della sentenza palermitana: “il rapporto di lavoro alle dipendenze di un’impresa non ha più ragion d’essere allorché il datore di lavoro non abbia più motivo di attendersi dal lavoratore impiegato la stessa utilitas che l’aveva indotto ad assumerlo...”. Delle due l’una: o con tale ragionamento il Giudice vuol ammettere che qualsivoglia decremento (purché esistente) della richiamata utilitas giustifichi il recesso per g.m.o. – e ciò costituirebbe una evidente aberratio – oppure vuole riconoscere che i motivi addotti dal datore di lavoro a sostegno del recesso debbano essere vagliati onde accertarne l’esistenza e l’idoneità – il che equivale a dire che bisogna capire se il recesso è giusto o meno (ovvero “ragionevole” ) e, pertanto, bisogna necessariamente riferirsi ad un certo livello, giusta relazione tra perdita attesa e costi, al di sotto/sopra del quale il licenziamento è legittimo/illegittimo. Da quanto detto, indi, il giudicare della liceità di un recesso per g.m.o. prescindendo dalla natura assicurativa del rapporto non sembra poggiare su solide e convincenti basi, bensì sembra essere decisamente ancorato alla tradizionale visione giurisprudenziale che molta fiducia ripone nel convincimento del singolo giudice che, però, “decide in proposito [...] in modo sovente imprevedibile, sotto l’influenza di circostanze ambientali che possono causare effetti irrazionali e addirittura paradossali” . 5. La tematica su cui ci si è, molto brevemente, soffermati è certamente molto appassionante: lo dimostrano i frequenti ed approfonditi interventi maturati, in contraddittorio con la giurisprudenza, nei quasi quarant’anni di applicazione della legge. Di fatto non è agevole, per chiunque, colmare le lacune che il legislatore ha lasciato: opportuno sarebbe, dunque, un intervento in materia. Dopo una fase volta a produrre chiarezza (non sarebbe inutile riaprire il dibattito alla luce del bilancio risultante dall’applicazione dell’art. 3 nelle aule giudiziarie) sarebbe certamente utile dare l’input ad una nuova fase volta a riformare l’esistente, giacché proprio l’assenza di parametri certi è alla base del discutere di cui, ivi, si dà notizia. In tal senso si potrebbe, come autorevolmente sostenuto, determinare per legge la soglia di sopportabilità della perdita attesa prodotta dalla prosecuzione del rapporto, utilizzando criteri di calcolo che tengano conto della posizione del lavoratore nella realtà produttiva, gli eventuali carichi di famiglia, l’anzianità, etc. Ovviamente l’indennità da pagare al lavoratore in caso di recesso dovrebbe coincidere proprio con il livello di soglia all’uopo stabilito, in modo da smascherare, applicando la regola del revelation principle, il datore di lavoro non disponibile a pagare. E’ chiaro che non risulta certo agevole, per il datore, calcolare quanto può costare mantenere in vita il rapporto e, quindi, confrontarsi con la soglia così determinata; deve però riconoscersi che, rebus sic stantibus, tali calcoli sono rimessi all’apprezzamento del giudice per il quale, di certo, risulta ancora più difficile districarsi in siffatto contesto. Diverse proposte di modifica sono state avanzate: la C.G.I.L. , per esempio, ha elaborato, nel marzo 2003, una proposta di legge di iniziativa popolare concernente “la estensione della tutela contro i licenziamenti ingiustificati” , prospettando una modifica integrativa dell’art. 3 l. n. 604/1966; si tratterebbe di aggiungere, dopo le parole “ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e di regolare funzionamento di essa” il periodo “purché il datore di lavoro abbia fatto preventivo ricorso a contratti di solidarietà, sospensioni da lavoro con integrazione salariale, o altri istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, di eliminazione anche temporanea dell’esubero con conservazione del rapporto di lavoro”. Orbene tale modifica non inciderebbe sul metodo di determinazione dell’entità del massimale lasciando, dunque, sempre all’interprete il compito di precisarla, in chiave tipicamente soggettiva e “intimistica” – piuttosto ne risulterebbe elevato solo il costo (contabile – opportunità) dell’operazione: il datore di lavoro, infatti, sarebbe costretto, prima di recedere, a sopportare il peso di una procedura finalizzata a “salvare” il posto di lavoro; tale proposta appare, in realtà, più orientata a limitare ulteriormente il potere datoriale, individuando una vera e propria condicio al recesso, ma solo per i casi di esubero in cui, come già detto, non si esaurisce interamente il fenomeno del g.m.o. , comprendendo esso diverse situazioni affatto contemplate dalla succitata proposta di modifica. Se è vero che il problema è a monte – immanente al concetto di soglia e derivante dalla stessa natura del rapporto di lavoro – meramente analgesico risulterà ogni intervento a valle, dal quale però alcun effetto tangibile potrebbe scaturire, in chiave patologica; gli operatori resterebbero costretti, infatti, a ricorrere ad una larga interpretatio – tangente l’arbitrio – al fine di giudicare lecito (o meno) il recesso ex art. 3. Ci si trova, dunque, in una fase di stallo in cui l’ago della bilancia è rappresentato proprio dal giudice che, chiamato ad operare con gli strumenti normativi vigenti ed interpretando in modo vario la regola, produce eterogenee decisioni, tali, da non consentire né ai datori di lavoro né ai lavoratori di poter prevedere quale effetto possa scaturire dall’applicazione dell’art. 3, l. n. 604/1966. note a piè di pagina Cfr. Trib. Palermo 10 dicembre 2003, con nota di F. STOLFA, RIDL,2004, III. Cfr. ICHINO, Il contratto di lavoro, vol. III, Trattato di Diritto Civile e Commerciale, 2003, con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Cfr. ICHINO, op. cit. ; GHERA, Diritto del Lavoro, Bari, 2003; MAZZOTTA, I licenziamenti, Milano, 1999; AMOROSO, DI CERBO, MARESCA, Statuto dei lavoratori e disciplina dei licenziamenti, in Le fonti del diritto italiano, vol. II, Milano, 2001; NAPOLI, La stabilità reale del posto di lavoro, Milano 1980; PERSIANI, La tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto, in NTDL, diretto da Riva Sanseverino e Mazzoni, vol. II, Padova, 1971; ICHINO, Il lavoro e il mercato, Milano, 1996; GIUGNI, Intervento, in I licenziamenti nell’interesse dell’impresa, Milano, 1969; A. e P. ICHINO, POLO, L’influenza delle condizioni del mercato del lavoro regionale sulle decisioni dei giudici in materia di licenziamento, in RIDL, 1998, I. Per un’impostazione parzialmente diversa cfr. NAPOLI, Questioni di diritto del lavoro, Torino, 1996, secondo cui bisognerebbe individuare un’unica ipotesi, nell’organizzazione del lavoro – regolare funzionamento di essa, considerandovi compresi tanto profili “statico-strutturali” quanto “dinamico-funzionali”. La disciplina dei licenziamenti (a cura di CARINCI), vol. II, 1991. NAPOLI, op. cit. MAZZOTTA, op. cit. GHERA, op. cit. ; cfr. anche PISANI, La reintegrazione nel posto di lavoro per ingiusta detenzione, in MGL , 1998; CASTELVETRI, SCARPELLI, La “Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione” in RIDL, 1996, III. PERA, La cessazione dei rapporti di lavoro, Padova, 1980. ICHINO, Appunti sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in RIDL, 1999, III. Tale attività non è ignota ai giudici italiani ai quali è rimesso il compito di svolgere valutazioni simili a quelle ivi citate anche in altri frangenti: si veda, ad esempio, l‘art. 844 c.c. – concernente le immissioni nocive – il quale espressamente si rivolge all’ ”autorità giudiziaria”, assegnandole il compito di individuare la “normale tollerabilità” senza, però, specificarne i confini e individuando, nel contemperamento delle “esigenze della produzione con la ragione della proprietà” e nella “condizione dei luoghi”, gli unici elementi necessariamente condizionanti la valutazione giudiziale (cfr. Cass. n. 6534/1985; Cass. n. 5157/1983). Trattasi, quindi, di un “esercizio” logico molto simile a quello cui si è supra cennato stante la necessità, per il giudice, di stabilire una soglia i cui confini siano coincidenti con quelli della “normale tollerabilità”, oltrepassata la quale l’immissione nociva si traduce in un atto illegittimo di cui il responsabile dovrà rispondere. In tal senso BLANCHARD, TIROLE, Profili di riforma dei regimi di protezione del lavoro, in RIDL, 2004, II. ICHINO, Il contratto... , cit. Di cui si trovano ampi riferimenti nei testi citati in note 1 e 3. ICHINO, op. ult. cit. FERRARI, Il problema dell’alea contrattuale, Napoli, 2001. ICHINO, op. ult. cit. FERRARI, Nuovi profili di diritto delle assicurazioni, Milano, 2003. Per la definizione di rischio, neutralizzazione e distinzione dall’alea contrattuale cfr. FERRARI, Il problema..., cit. Cass. , Sez. Lav. , 5 marzo 2003, n. 3250, in RIDL, 2003, III, La giurisprudenza che fa discutere – Un caso interessante per la riflessione sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento: due opinioni, con interventi di ICHINO e CAVALLARO. ICHINO, Appunti sul giustificato motivo ... , cit. ICHINO, Il lavoro e il mercato, cit. In www.CGIL.it . |
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |
|||


